| |
(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti,
Milano-Roma, 1924-25)
|
Pag. 2/2 |
|
L'ARTE DI VINCENZO GEMITO E SETTE RITRATTI
INEDITI
|
|
|
 Si aggiunga che un altro pericolo gli sovrastava. Era anche
questo comune ai più degli scultori tra il 1870 e il 1890;
ma per lui abilissimo e dedito al continuo disegnare, era
anche più minaccioso. Intendo il pericolo della pittura
fattasi allora maestra della scultura. I disegni, gli
acquerelli, i pastelli di Vincenzo Gemito sembrano, i più,
opera d'un pittore non d'uno scultore: specie, i disegni a
penna, stupendi ma rapidi, rotti, vibranti di luce, con un
chiaroscuro magistrale cui súbito l'artista apponeva, senza
pentimenti, qua il massimo d'ombra, là il massimo di luce.
La maniera di questi disegni deriva dall'esempio di Mariano
Fortuny che nell'estate del 1874 dimorò a Portici nella
villa Arata e, ospitale e liberale, teneva giorno e notte la
casa aperta ai giovani colleghi di laggiù: Gemito, Mancini,
Dal bono, in prima fila. Non è in queste carte la sobrietà e
fermezza dei profili, il netto rilievo dei pochi piani
essenziali, il germe insomma della statua che fanno al primo
sguardo riconoscere il disegno d'uno scultore, da
Michelangelo a Canova.
Si aggiunga che un altro pericolo gli sovrastava. Era anche
questo comune ai più degli scultori tra il 1870 e il 1890;
ma per lui abilissimo e dedito al continuo disegnare, era
anche più minaccioso. Intendo il pericolo della pittura
fattasi allora maestra della scultura. I disegni, gli
acquerelli, i pastelli di Vincenzo Gemito sembrano, i più,
opera d'un pittore non d'uno scultore: specie, i disegni a
penna, stupendi ma rapidi, rotti, vibranti di luce, con un
chiaroscuro magistrale cui súbito l'artista apponeva, senza
pentimenti, qua il massimo d'ombra, là il massimo di luce.
La maniera di questi disegni deriva dall'esempio di Mariano
Fortuny che nell'estate del 1874 dimorò a Portici nella
villa Arata e, ospitale e liberale, teneva giorno e notte la
casa aperta ai giovani colleghi di laggiù: Gemito, Mancini,
Dal bono, in prima fila. Non è in queste carte la sobrietà e
fermezza dei profili, il netto rilievo dei pochi piani
essenziali, il germe insomma della statua che fanno al primo
sguardo riconoscere il disegno d'uno scultore, da
Michelangelo a Canova.
Gemito non pensa che ai giochi della luce sulle vesti, sui
capelli, sulle carni, sull'aria attorno, così che i contorni
si disfanno e svaporano delicatamente nello sfondo. Anche
Domenico Morelli allora disegnò così: ma era un pittore.
Cogli anni i disegni di Gemito sono divenuti più semplici e
incisi; ma qui io parlo degli anni della sua creazione più
vivace, tra i venti e i quaranta. E quando da Napoli nel
1877 pieno di speranza e di stupore egli andò a Parigi la
prima volta, a raggiungere il suo amico Mancini e ad esporre
il suo Pescatore nel Salon "che è più grande (scriveva) del
Palazzo Reale di Caserta", dall'affettuosa protezione del
Fortuny passò alla paterna amicizia del Meissonier. Era la
pittura di costui più ferma e ragionata, senza i brividi e
lo sfavillio di quella fortuniana, ma altrettanto minuta e
spezzata.
|
 Risale a quelli anni, tanto la novità di questa confusione
sembrava seducente, la scultura milanese detta
impressionista, la scultura cioè di Giuseppe Grandi e poi di
Ernesto Bazzaro, di Medardo Rosso, di Paolo Trubetzkoi,
scultura di pittori anche quella, opposta alla scultura, per
non dire d'altri, del Vela. Parlo, s'intende, del Vela
quando è profondo e ben piantato nel suo sodo verismo, del
Vela che ha scolpito il Cavour di Genova o il Napoleone
morente di Versailles. Eppure anch'egli nel 1882, più che
sessantenne, quando modellò il gran rilievo delle "Vittime
del lavoro nel traforo del Gottardo", si piegò alla maniera
dei giovani milanesi, quasi ad affermare, lui ultimo
rampollo dei robusti e quadrati comacini: ? Sono pittore
anche io. ? Ma la scultura pittoresca dei lombardi,
provandosi a rendere con colpi di spatola e di pollice sulla
creta, con scheggiature a conchiglia e tremule marezzature
sul marmo, l'indefinita e superficiale carezza della luce,
ebbe anche un merito: quello d'abolire il fastidio dei
particolari minuti, del tritume realistico caro agli altri
scultori, e sopra tutto ai meridionali. Fu allora che gli
scultori cominciarono ad avere paura del marMo severo e
dell'inesorabile scalpello, e a non modellare più che in
creta e in cera pel fluido bronzo. Ne da questa paura molti
sono ancóra guariti, anche perchè, dopo tanto abbandono, la
pratica del marmo si può dire, negli artisti, perduta, e i
più "monumentali" si devono affidare agli artigiani di
Carrara e di Pietrasanta perché traducano essi nel marmo i
loro gran gessi.
Risale a quelli anni, tanto la novità di questa confusione
sembrava seducente, la scultura milanese detta
impressionista, la scultura cioè di Giuseppe Grandi e poi di
Ernesto Bazzaro, di Medardo Rosso, di Paolo Trubetzkoi,
scultura di pittori anche quella, opposta alla scultura, per
non dire d'altri, del Vela. Parlo, s'intende, del Vela
quando è profondo e ben piantato nel suo sodo verismo, del
Vela che ha scolpito il Cavour di Genova o il Napoleone
morente di Versailles. Eppure anch'egli nel 1882, più che
sessantenne, quando modellò il gran rilievo delle "Vittime
del lavoro nel traforo del Gottardo", si piegò alla maniera
dei giovani milanesi, quasi ad affermare, lui ultimo
rampollo dei robusti e quadrati comacini: ? Sono pittore
anche io. ? Ma la scultura pittoresca dei lombardi,
provandosi a rendere con colpi di spatola e di pollice sulla
creta, con scheggiature a conchiglia e tremule marezzature
sul marmo, l'indefinita e superficiale carezza della luce,
ebbe anche un merito: quello d'abolire il fastidio dei
particolari minuti, del tritume realistico caro agli altri
scultori, e sopra tutto ai meridionali. Fu allora che gli
scultori cominciarono ad avere paura del marMo severo e
dell'inesorabile scalpello, e a non modellare più che in
creta e in cera pel fluido bronzo. Ne da questa paura molti
sono ancóra guariti, anche perchè, dopo tanto abbandono, la
pratica del marmo si può dire, negli artisti, perduta, e i
più "monumentali" si devono affidare agli artigiani di
Carrara e di Pietrasanta perché traducano essi nel marmo i
loro gran gessi.
|
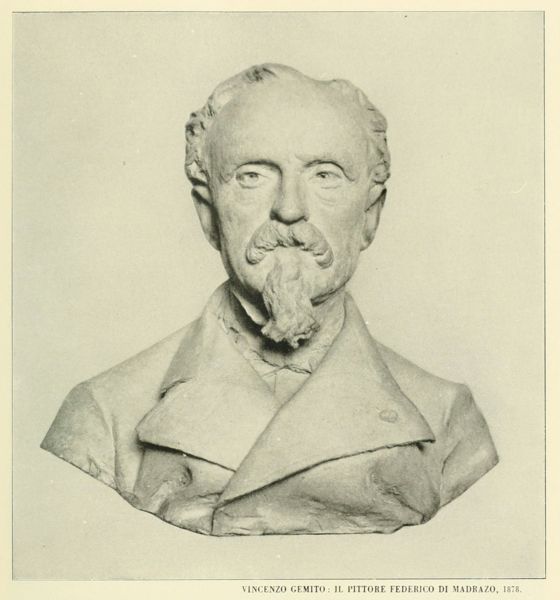 Così fu di Gemito, rimasto anch'egli più affezionato alla
stecca che al mazzuolo e allo scalpello. Anch'egli si
divertì spesso a strappare pittorescamente spalle e petti e
colli tanto da evitare il classico taglio regolare e
simmetrico dei ritratti antichi a busto e ad erma.
Anch'egli, nel trattare vesti, camice, cravatte, capelli,
baffi, volle essere più pittore di tremulo chiaroscuro che
scultore di masse e volumi. Ma, conosciuti i suoi limiti,
concentrata la sua attenzione sui volti, eccolo tutto
intento a rendere plasticamente l'espressione singolare, a
ricercare sotto la pelle e la carne l'impalcatura dell'ossa,
a definire giro giro i profili così da darti da ogni lato la
sensazione del volume pieno e da farti sentire l'appoggio e
la resistenza di quel che v'è dall'altra parte: a fare
insomma opera di scultore. Alla moda cedette gli accessori,
all'arte sua serbò il principale. E a tutti i modelli,
perfino a questo giovane "Pescatore " (pag. 331), perfino
alle belle popolane che ho ricordate più sopra, dette, pur
nella varietà degli animi da raffìgurare, la dignità e
gravità che rispondevano allo scontroso animo suo e al suo
intimo tormento, e che ritroviamo in tutti i suoi
autoritratti: dignità e gravità tanto lontana dalla
spensieratezza degli artisti suoi contemporanei nell'era
umbertina, quanto vicina, dal Preti al Toma, alla pensosa
malinconia della più durevole e memorabile arte meridionale.
Così fu di Gemito, rimasto anch'egli più affezionato alla
stecca che al mazzuolo e allo scalpello. Anch'egli si
divertì spesso a strappare pittorescamente spalle e petti e
colli tanto da evitare il classico taglio regolare e
simmetrico dei ritratti antichi a busto e ad erma.
Anch'egli, nel trattare vesti, camice, cravatte, capelli,
baffi, volle essere più pittore di tremulo chiaroscuro che
scultore di masse e volumi. Ma, conosciuti i suoi limiti,
concentrata la sua attenzione sui volti, eccolo tutto
intento a rendere plasticamente l'espressione singolare, a
ricercare sotto la pelle e la carne l'impalcatura dell'ossa,
a definire giro giro i profili così da darti da ogni lato la
sensazione del volume pieno e da farti sentire l'appoggio e
la resistenza di quel che v'è dall'altra parte: a fare
insomma opera di scultore. Alla moda cedette gli accessori,
all'arte sua serbò il principale. E a tutti i modelli,
perfino a questo giovane "Pescatore " (pag. 331), perfino
alle belle popolane che ho ricordate più sopra, dette, pur
nella varietà degli animi da raffìgurare, la dignità e
gravità che rispondevano allo scontroso animo suo e al suo
intimo tormento, e che ritroviamo in tutti i suoi
autoritratti: dignità e gravità tanto lontana dalla
spensieratezza degli artisti suoi contemporanei nell'era
umbertina, quanto vicina, dal Preti al Toma, alla pensosa
malinconia della più durevole e memorabile arte meridionale.
Il busto di Giuseppe Verdi, a capo basso, modellato pei
buoni offici del Morelli quando il maestro andò a Napoli a
porre in scena al San Carlo l'"Aida" e il "Don Carlos"
(9),
è del 1873; il busto di Domenico Morelli è dell'anno dopo.
Sono tutti e due notissimi. Dello stesso anno 1871 è questa
fiera testa di Francesco Paolo Michetti (tav. fuori testo e
pag. 318). A cinquant'anni di distanza Michetti gli
assomiglia ancóra, tanto bene negli zigomi distanti e
prominenti, nel cavo tra essi e la bocca, nella fronte
rotonda, nelle tempie larghe e piane, nell'arco fondo
dell'orbite, lo scultore ha modellato questo cranio, ha
ritrovato nell'ossa il piglio risoluto della testa
sull'esile collo. E uno dei più vivi ritratti del nostro
ottocento. Basta seguirne il profilo per sentire la fermezza
della mano di chi l'ha modellato. Basta osservarne il
chiaroscuro che dal cupo foro delle pupille si distribuisce
sobriamente su tutto il chiaro volto giovanile, per
immaginare che ritrattista sarebbe stato Vincenzo Gemito se
intorno a lui non soltanto i pittori si fossero accorti
della sua potenza. L'arte qui sta nascosta dietro l'opera:
che è il proprio dei classici. Senza quei tocchi di
pittoresca bravura nei capelli, a ritrovare questa
terracotta nel fondo d'un museo la si direbbe antica.
|
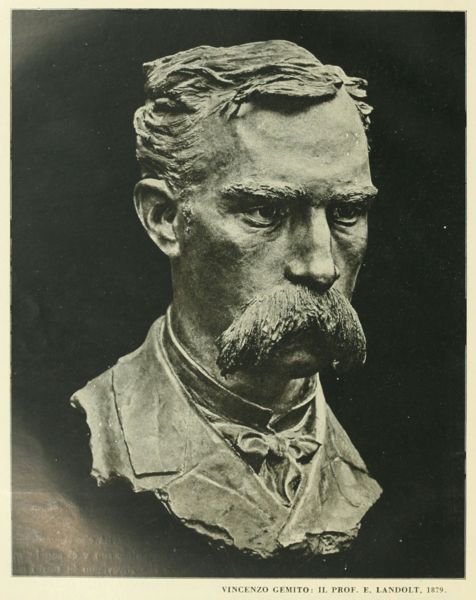
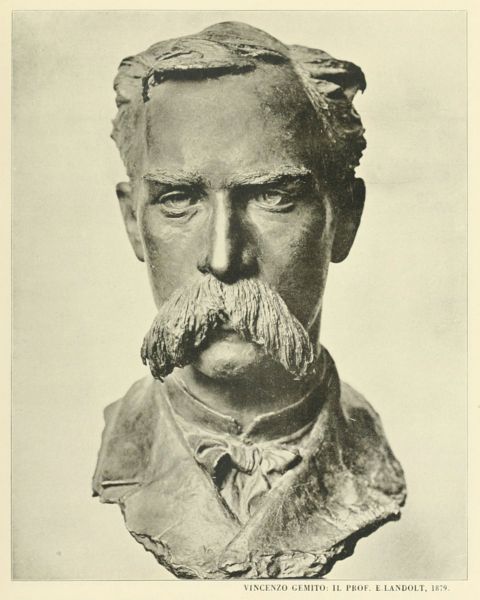 Nella terracotta di Mariano Fortuny, anch'essa del 1874,
quella bravura si sbizzarisce anche più (pagg. 320-321). Le
masse pesanti dei capelli ricciuti, le pieghe di quel poco
di giubba aperta sul collo pesante sono traforate, come nel
busto di Domenico Morelli, da neri uguali e inconcludenti.
Ma nel maschio volto, se lo volgi lentamente a considerarne
tutti i profili, ritrovi la scelta e i riposi che fanno lo
stile. Lo stesso si dica del ritratto Landolt (pag. 328),
anch'esso, come quello del Fortuny, col capo un poco piegato
in avanti così da soggiogarti con lo sguardo. Ma là v'è la
mobilità d'un pittore; qui la composta calma d'uno
scienziato. Anche nel ritratto Landolt ciò che prima
colpisce, è nella fronte, nel naso, nella mascella, la
nitidezza della costruzione ossea, così sicura che questo
volto ti sembra che prima sia stato modellato scarnito e poi
vi sieno state appiccate cartilagini, muscoli, pelle e pelo.
Nella terracotta di Mariano Fortuny, anch'essa del 1874,
quella bravura si sbizzarisce anche più (pagg. 320-321). Le
masse pesanti dei capelli ricciuti, le pieghe di quel poco
di giubba aperta sul collo pesante sono traforate, come nel
busto di Domenico Morelli, da neri uguali e inconcludenti.
Ma nel maschio volto, se lo volgi lentamente a considerarne
tutti i profili, ritrovi la scelta e i riposi che fanno lo
stile. Lo stesso si dica del ritratto Landolt (pag. 328),
anch'esso, come quello del Fortuny, col capo un poco piegato
in avanti così da soggiogarti con lo sguardo. Ma là v'è la
mobilità d'un pittore; qui la composta calma d'uno
scienziato. Anche nel ritratto Landolt ciò che prima
colpisce, è nella fronte, nel naso, nella mascella, la
nitidezza della costruzione ossea, così sicura che questo
volto ti sembra che prima sia stato modellato scarnito e poi
vi sieno state appiccate cartilagini, muscoli, pelle e pelo.
Dove ritroviamo tanta sagacia, prima nel vedere e poi nello
sceverare i tratti d'un volto, tanta unità e solidità nel
costruirlo? La ritroviamo nei busti romani del Museo
nazionale di Napoli, dall'asciutta faccia detta di Celio
Caldo al morbido volto detto di Bruto minore. L'arte di
Vincenzo Gemito si formò purtroppo in tristi anni quando i
giovani non si credevano destinati alla gloria se non
maledivano i musei. Il vezzo è continuato fino a che i
futuristi hanno codificato quindici o vent'anni fa i
benefici e i comodi dell'ignoranza. Di questa stoltezza
durata mezzo secolo si vedono ogni giorno i leggiadrissimi
effetti. Ma tra il 1870 e il 1880 quel vezzo era ancóra
recente, e la tradizione era ancóra tanto viva che, volenti
o nolenti, gli artisti più capaci ne sentivano per fortuna i
sicuri puntelli. Anche oggi vien fatto di ritrovare,
percorrendo le pinacoteche di Toscana, nei fondi dei quadri
della rinascenza, da quelli dell'Angelico a quelli di Fra
Bartolomeo, paesaggi che sembrano veduti, sentiti, dipinti
da Giovanni Fattori.
|
 Certo
un poco d'indulgenza è necessaria in confronti siffatti; nè è detto che spregio e ferocia
giovino alla perspicacia d'un critico. Forse il confronto
con l'antico sarà per molti più agevole considerando, ad
esempio, la testa del "Filosofo" modellata da Gemito nel
1883, perchè lì anche l'acconciatura ci aiuta. Ma a noi la
somiglianza sembra molto più evidente davanti a questa testa
di "Pescatore" (pag. 331), e a questo ritratto di Francesco
Paolo Michetti. Già l'intuì Gabriele d'Annunzio nelle
armoniose pagine su Vincenzo Gemito preposte all'Ode per
Giuseppe Verdi: "A Napoli fioriva un giovinetto meraviglioso
che pareva nato veramente d'una di quelle antiche stirpi
migranti dall'Ellade alle rive della Campania... 55
(10). Certo
un poco d'indulgenza è necessaria in confronti siffatti; nè è detto che spregio e ferocia
giovino alla perspicacia d'un critico. Forse il confronto
con l'antico sarà per molti più agevole considerando, ad
esempio, la testa del "Filosofo" modellata da Gemito nel
1883, perchè lì anche l'acconciatura ci aiuta. Ma a noi la
somiglianza sembra molto più evidente davanti a questa testa
di "Pescatore" (pag. 331), e a questo ritratto di Francesco
Paolo Michetti. Già l'intuì Gabriele d'Annunzio nelle
armoniose pagine su Vincenzo Gemito preposte all'Ode per
Giuseppe Verdi: "A Napoli fioriva un giovinetto meraviglioso
che pareva nato veramente d'una di quelle antiche stirpi
migranti dall'Ellade alle rive della Campania... 55
(10).
Il giovane scultore, senza maestri a Napoli e senza compagni
degni di lui, dibattendosi tra la povertà e la speranza, tra
l'oscurità e l'ambizione, tra la tentazione, della maniera
in voga e la nativa aspirazione del suo genio, condannato a
vivere in tempi gretti e miopi quando la lode è più dolorosa
dell'offesa, dovette anch'egli sentire la grandezza e la
miseria del suo destino. Nell'aprile 1878 in una lettera
alla povera donna che l'aveva raccolto e le aveva fatto da
madre, scriveva, di questi busti, da Parigi così:
"All'Esposizione Universale ho esposto il Morelli e il
Verdi. Al Salon metterò il ritratto di Fortuny e quello di
Faure. Forse vi salverò da tanti guai. Forse ritornerò
grande". Nove anni dopo sprofondava nella follia. Ne è
emerso, vecchio e stupefatto, da pochi anni. Oggi ne ha
settantadue.
|
|
UGO OJETTI
|
|
Ritorno - Pagina 1/2
|
|
|
|
|
|
|
|