| |
(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti - Milano -
Roma - 1920)
|
|
|
IL PITTORE OSCAR GHIGLIA
|
|
|
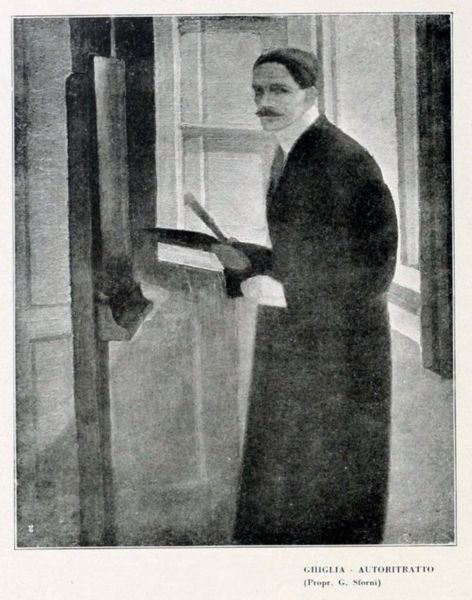 Sbaglia chi da lontano immagina i livornesi simili agli
altri toscani. Livorno, è il gran porto da dove nella
Toscana agricola e casalinga, serrata tra Appennino e
Maremma, entrano la curiosità dell' avventura, l'amore del
rischio, la nostalgia del largo e le favole dell'ignoto.
Livorno, come città di porto, a nata soltanto alla fine del
cinquecento sotto Ferdinando primo de' Medici che tanto
l'amava da chiamarla la sua dama; gente nova, oggi si
direbbe americani, a confronto di senesi, fiorentini,
lucchesi e aretini e dei loro secoli etruschi e romani.
L'indulto che il novello Romolo emanò nel 1593 invitava, "
ponentini, spagnoli, portoghesi, greci, italiani, ebrei,
turchi, mori, persiani ed altri ? a fissarsi col loro
traffico in quel suo nuovo emporio. Quel che in pieno
seicento dette la barocca e industriosa miscela non poteva
essere arte : furono, benedetti, commercio e danaro. Per
scorgere un'arte livornese, si dovette aspettare l'amalgama
dei secoli, di due o tre secoli; si dovette aspettare che da
quella singolare postura e singolarissima popolazione si
formassero una civiltà e quasi un'anima livornese.
Quest'anima oramai c'e, visibile e inconfondibile. Una
caustica vivacità, una spensierata generosità, un'audacia
tra gentile e spavalda che sa sempre di marinaresco, un
impeto e un orgoglio temperati da uno scetticismo
argutissimo, un saper rinnovarsi secondo gli avversari e gli
eventi,un darsi senza abbandonarsi, un riprendersi senza
abbandonare, una malinconia che mai dispera ma quasi gode
nuovo sapore del mondo con quella salsa d'amaro, danno ai
livornesi un temperamento tra guascone e nordamericano, una
salute morale giovanile ed accesa per la quale essi non
perdono mai di vista il vero, e prima lo pesano e lo
misurano a scanso di equivoci e d'inganni, e poi se lo
abbelliscono per amarlo meglio e anche perchè gli altri lo
invidino di più.
Sbaglia chi da lontano immagina i livornesi simili agli
altri toscani. Livorno, è il gran porto da dove nella
Toscana agricola e casalinga, serrata tra Appennino e
Maremma, entrano la curiosità dell' avventura, l'amore del
rischio, la nostalgia del largo e le favole dell'ignoto.
Livorno, come città di porto, a nata soltanto alla fine del
cinquecento sotto Ferdinando primo de' Medici che tanto
l'amava da chiamarla la sua dama; gente nova, oggi si
direbbe americani, a confronto di senesi, fiorentini,
lucchesi e aretini e dei loro secoli etruschi e romani.
L'indulto che il novello Romolo emanò nel 1593 invitava, "
ponentini, spagnoli, portoghesi, greci, italiani, ebrei,
turchi, mori, persiani ed altri ? a fissarsi col loro
traffico in quel suo nuovo emporio. Quel che in pieno
seicento dette la barocca e industriosa miscela non poteva
essere arte : furono, benedetti, commercio e danaro. Per
scorgere un'arte livornese, si dovette aspettare l'amalgama
dei secoli, di due o tre secoli; si dovette aspettare che da
quella singolare postura e singolarissima popolazione si
formassero una civiltà e quasi un'anima livornese.
Quest'anima oramai c'e, visibile e inconfondibile. Una
caustica vivacità, una spensierata generosità, un'audacia
tra gentile e spavalda che sa sempre di marinaresco, un
impeto e un orgoglio temperati da uno scetticismo
argutissimo, un saper rinnovarsi secondo gli avversari e gli
eventi,un darsi senza abbandonarsi, un riprendersi senza
abbandonare, una malinconia che mai dispera ma quasi gode
nuovo sapore del mondo con quella salsa d'amaro, danno ai
livornesi un temperamento tra guascone e nordamericano, una
salute morale giovanile ed accesa per la quale essi non
perdono mai di vista il vero, e prima lo pesano e lo
misurano a scanso di equivoci e d'inganni, e poi se lo
abbelliscono per amarlo meglio e anche perchè gli altri lo
invidino di più.
|
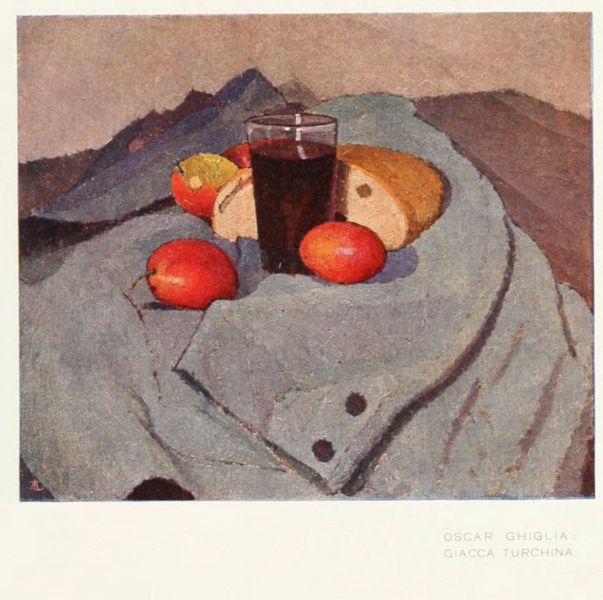 Il pittore Oscar Ghiglia è livornese. Certo con la sua
patria non si spiega tutta l'arte sua, e nemmeno quella di
Giovanni Fattori anch'egli purissimo livornese e venerato
dal Ghiglia come un maestro. Ma anche è certo che a
trasporre in arte le dette qualità di cuore, di cervello, di
costume dei livornesi, le si ritrovano tutte nella pittura
di Oscar Ghiglia, per fortuna della sua sincerità. La
pittura è infatti per lui, non un modo d'inventare o
sognare, ma un modo di capire, ordinare, dominare, godere il
vero e renderlo con l'arte prezioso, durevole e desiderabile
: prezioso prima di tutto per lui che lo guarda, lo ama, lo
gode. E pittura d'un sensuale sano e consapevole, che non
vuole saperne d'astrazione e di fantasia e cerca un suo
rapimento ideale nel possesso, anzi dominio, di quel che
tocca e vede. Toccare. Pare che Oscar Ghiglia tocchi le cose
prima di vederle, e quando si mette a guardarle, a
studiarle, a definirne forme, luci, riflessi, lo faccia per
moltiplicare la tattilità delle sue dita come fanno gli
adoratori della scultura che a un certo punto socchiudono
gli occhi e passano la mano sopra una spalla, una gola, una
tempia di marmo per sentirne meglio, toccandoli, tutti i
dolcissimi piani e da quelli giudicare la finezza dell'arte.
Il pittore Oscar Ghiglia è livornese. Certo con la sua
patria non si spiega tutta l'arte sua, e nemmeno quella di
Giovanni Fattori anch'egli purissimo livornese e venerato
dal Ghiglia come un maestro. Ma anche è certo che a
trasporre in arte le dette qualità di cuore, di cervello, di
costume dei livornesi, le si ritrovano tutte nella pittura
di Oscar Ghiglia, per fortuna della sua sincerità. La
pittura è infatti per lui, non un modo d'inventare o
sognare, ma un modo di capire, ordinare, dominare, godere il
vero e renderlo con l'arte prezioso, durevole e desiderabile
: prezioso prima di tutto per lui che lo guarda, lo ama, lo
gode. E pittura d'un sensuale sano e consapevole, che non
vuole saperne d'astrazione e di fantasia e cerca un suo
rapimento ideale nel possesso, anzi dominio, di quel che
tocca e vede. Toccare. Pare che Oscar Ghiglia tocchi le cose
prima di vederle, e quando si mette a guardarle, a
studiarle, a definirne forme, luci, riflessi, lo faccia per
moltiplicare la tattilità delle sue dita come fanno gli
adoratori della scultura che a un certo punto socchiudono
gli occhi e passano la mano sopra una spalla, una gola, una
tempia di marmo per sentirne meglio, toccandoli, tutti i
dolcissimi piani e da quelli giudicare la finezza dell'arte.
La pennellata del Ghiglia è densa, netta e meditata, distesa
in un senso solo per ogni piano : non larga ma uguale, cosi
da riempire con tante pennellate parallele gli spazi di quel
tono. Se scopre un'altra sfumatura, la isola, e quell?
isolamento riempie con sicure pennellate ancora d'un sol
tono, lasciando spesso visibile tra una toppa e l'altra il
primo disegno turchino o una riga di fondo che l'incastoni.
Niente e approssimativo o casuale; niente sospiro; tutto
parola precisa e sonora; tutto capito e definito con una
mente avveduta e limpida quanto l?occhio: limpida ma cosi
finemente amorosa che questa sagace e minuta definizione
della realtà per toppe di colori e di riflessi non riesce
mai a fredde scomposizioni geometriche o ad astrazioni
decorative da tappeto o da intarsio, ma si presenta vero,
vivo, solido, profondo e bello, anzi più bello perchè
riordinato, stabile e tutto prezioso. La composizione che lo
riordina è semplice. Il centro d'un quadro del Ghiglia è
quasi sempre il suo centro d'equilibrio, e la figura e
l'oggetto posti in questo centro sono saldi e compatti di
peso e di colore. Anche nelle "nature morte? quel
casuale e quello spezzato di talune "nature morte?
secentesche e anche, in Francia, recenti, che non sai perche
non continuino per un altro palmo o un altro metro, ripugna
a questo pittore-architetto che va spegnendo i suoi rilievi
da quel centro fino alla cornice con gradazioni definite e
lisci riposi senza abbandonare al caso dello sfumato un
centimetro della sua tela, ma riempiendola tutta della sua
lucida volontà.
Volontà di ricchezza. La materia pittorica di Oscar Ghiglia
d'una ricchezza di gemma, rara e forse unica nella magra
pittura dei toscani dell'ottocento. Non e quella marrana
lotosa abbondanza d'impasti, scolature, riccioli, frange,
schiaffate là con la spatola o col tubetto stesso, cara
ancora a qualche tisicuccio che s'atteggia ad Ercole. Questa
del Ghiglia e ricchezza da signore, linda e piana,
distribuita con delicata generosità. Trascurare un angolo o
un centimetro del suo quadro sarebbe per lui come pei poeti,
quando scrivevano in versi, trascurare una sillaba o un
accento. E per gli amici che hanno conosciuto Oscar Ghiglia
nei giorni della sua impavida povertà, niente era più
commovente che vedere apparire sul cavalletto nella stanza
nuda uno di questi suoi quadri cosi pieni, solidi, lucenti,
preziosi.
|
 Egli aveva a mostrarli le ritrosie e le cautele dell'avaro
che nasconde il suo tesoro, e a vedervi ammirazione frizzava
tutto in un livornesissimo sorrisetto tra soddisfatto e
scanzonato, che certo voleva dire il povero è lei perche io,
vede, i tesori me li so creare, quando voglio, da me. Un
quadro alla volta vi mostrava e finchè l'uno non era tornato
nel suo nascondiglio con la faccia al muro, l'altro non
appariva. Gli piaceva tra la Luce di due pitture lasciarvi
patire per qualche minuto l'ordinato e spolverato squallore
della sua stanza, come una pausa, e come un monito che
sapeva d'orgoglio. E poteva aver bisogno di cento lire, ma
al compratore il suo quadro si divertiva a farglielo
sospirare, perche imparasse a desiderarlo, cioè ad amarlo.
Si pensi che a questa pittura ricca, meditata, nitida e
compiuta, Oscar Ghiglia è venuto fin da vent'anni fa, quando
furoreggiava in Italia quell' impressionismo di seconda mano
pei cui seguaci costruirsi un quadro meditatamente e fuori
dell'aria aperta e dipingerlo tutto senza comodi abbandoni,
ripieghi, svolazzi, vuoti e sprezzature, era un segno di
cecità filistea. Per la prima volta Oscar Ghiglia era venuto
a Firenze nel dicembre del 1900, e allora per la prima volta
aveva veduto i musei e per la prima volta aveva parlato col
suo conterraneo Giovanni Fattori, semplice e solitario,
professore dell'Accademia (cento lire al mese di stipendio).
Egli aveva a mostrarli le ritrosie e le cautele dell'avaro
che nasconde il suo tesoro, e a vedervi ammirazione frizzava
tutto in un livornesissimo sorrisetto tra soddisfatto e
scanzonato, che certo voleva dire il povero è lei perche io,
vede, i tesori me li so creare, quando voglio, da me. Un
quadro alla volta vi mostrava e finchè l'uno non era tornato
nel suo nascondiglio con la faccia al muro, l'altro non
appariva. Gli piaceva tra la Luce di due pitture lasciarvi
patire per qualche minuto l'ordinato e spolverato squallore
della sua stanza, come una pausa, e come un monito che
sapeva d'orgoglio. E poteva aver bisogno di cento lire, ma
al compratore il suo quadro si divertiva a farglielo
sospirare, perche imparasse a desiderarlo, cioè ad amarlo.
Si pensi che a questa pittura ricca, meditata, nitida e
compiuta, Oscar Ghiglia è venuto fin da vent'anni fa, quando
furoreggiava in Italia quell' impressionismo di seconda mano
pei cui seguaci costruirsi un quadro meditatamente e fuori
dell'aria aperta e dipingerlo tutto senza comodi abbandoni,
ripieghi, svolazzi, vuoti e sprezzature, era un segno di
cecità filistea. Per la prima volta Oscar Ghiglia era venuto
a Firenze nel dicembre del 1900, e allora per la prima volta
aveva veduto i musei e per la prima volta aveva parlato col
suo conterraneo Giovanni Fattori, semplice e solitario,
professore dell'Accademia (cento lire al mese di stipendio).
Il Fattori lo aiutò, e non solo di consigli, che gli permise
di frequentare la scuola del nudo e, qualche sera, di
dormire, in mancanza di meglio, nel suo studio. Narra lo
stesso Ghiglia che "il Fattori adorava gli antichi,
quelli che allora non si sa perchè, si chiamavano i
primitivi, e parlava di Giotto con venerazione e conoscenza,
senza parole difficili ma da vicino. ? Giotto, Fattori.
Questo binomio che non schiaccia il Fattori, adesso e
diventato d' uso corrente fra i molti glorificatori a voce e
in iscritto, del vecchio macchiaiolo livornese "che
parlava poco, non discuteva mai ? e dipingeva sempre ;
ma non credo che allora al Ghiglia apparisse tanto sicuro e
preciso. Certo la sua venuta a Firenze, la venuta di lui
provinciale (spregiudicato ma provinciale) alla capitale, lo
confortò in tre idee : che a dir arte moderna per intendere
qualcosa di terribilmente nuovo, primigenio e antitetico on
l'arte passata si dice una presuntuosa sciocchezza degna
davvero di provinciali educati al Caffè del Progresso,
perche l'arte che importa e una sola, senza aggettivi, e
moderno può anche essere un aggettivo peggiorativo; che il
vero, il vero tangibile, osservato con amore, posseduto con
voluttà, nettamente contornato e limpidamente colorito, e il
solo scopo dell'arte; che darsi all'arte vuol dire oggi
darsi a soffrire, quasi senza speranza.
Ancora nel 1913 scrivendo l'elogio, " io livornese e
pittore
? , di Giovanni Fattori a capo d'un bel volume dove per
la prima volta il Fattori stabile e maggiore fu separato, in
belle riproduzioni, dal Fattori corsivo e minore, Oscar
Ghiglia scriveva di lui e di se stesso : "Comprese che la
pittura è fondata unicamente sulla legge del saper trovare
il tono giusto d'un colore e costringerlo nel suo giusto
spazio, e che l'emozione che fa sorgere l'idea nella mente
del pittore e data soltanto dalle dimensioni dei colori,
dalle irradiazioni che la luce ne fa emanare per la simpatia
che li avvicina, e dalle distanze rispettive. ?
(1)
Quanto al soffrire il Fattori gli disse allora, e gli ripeté
anche pochi giorni prima di morire: " Tu sarai sempre
povero perchè sei un artista
". Profezia un po' romantica, che il giovane Ghiglia
accettò con serenità e anche con orgoglio, perche in tutte e
due le proposizioni capì che il buon maestro sottintendeva "come
me ? : e questo confronto al Ghiglia importava più della
povertà obbligatoria. Il fatto si è che tornato a Livorno
egli volle conoscere se stesso: contare e pesare quel suo
corporale patrimonio, che non ne aveva altri e forse il
cavalletto su cui dipinse quelle tre tele nemmeno era suo.
Non dico che quel soggetto egli lo scegliesse col deliberato
proposito di farsi un profondo esame di dentro e di fuori.
Ma in quella prima scelta c'è tutto Ghiglia: la sua
istintiva volontà di capire, la sua diffidenza e
scontentezza anche verso se stesso, la sua incapacità
d'essere felice se non vede e non sa e non rende a parole o
a colori limpidamente, tutto quel che il suo occhio e la sua
intelligenza gli possono rivelare delle cose, degli uomini,
delle idee. Ma per capire questa psicologia, bisogna
conoscere la sua vita fino allora.
Era nato il 23 agosto 1876. Suo padre, Valente Ghiglia, era
un piemontese, di Torino, anzi dei "Granatieri di Sardegna ?
venuti in Toscana con le truppe piemontesi dopo il 1860,
sposatosi a Livorno, congedatosi dall'esercito e impiegatosi
in quel Comune. Morì a quarantadue anni lasciando, in una
casuccia di via Paoli verso Porta alle Colline, la vedova
con tre figli. Oscar era il più piccino, di salute un
coccio, libero, appena si resse sulle gambe, d'andare dove
voleva, ad ogni ora. E naturalmente andava giù al mare e al
porto. Ma verso i dodici anni dovette anche pensare a
lavorare. Lo collocarono in una fonderia primitiva, a tirare
il mantice, poi a preparare e ripulire le " anime ? per le
fusioni in bronzo e in ottone: cannelli, bocchette,
rubinetti e palle da ornare le spalliere dei letti: roba già
che pesava e splendeva. E i soldi che guadagnava erano tanto
pochi che ogni giorno se li mangiava in ciliege.
|
 S'ammalò, si rimise su alla meglio e fu tolto dalla
fonderia. Un siciliano che commerciava in agrumi se lo portò
a Pistoia, sul mercato, tra le ceste d?aranci gialli e di
limoni verdi ; un grossista di Viterbo se lo portò a Viterbo
a vendere cioccolata, cotonate, colori. Nella mesticheria
del viterbese, Oscar Ghiglia ha primamente imparato i nomi e
le materie dei colori ; colori, s' intende, da imbianchino e
da verniciatore. Per allora non desiderava che maggior
liberta e perciò a diciassett'anni, quando i suoi bei
colleghi borghesi studiano calligrafia d'arte nelle
Accademie, si dette a fare il merciaio ambulante : tele,
nastri, stringhe, spille, bottoni e matite. Una cassetta
sulle spalle o un carrettuccio da spingere a braccia e via
sulle strade bianche di Lunigiana, a Serravezza, a Massa, a
Carrara, a Pietrasanta. Sole, polvere, fango e stanchezza ;
compagnie losche ; gergo di vagabondi ; lezzo d'osterie ; e
ad ogni svolta di strada il respiro del gran mare, libero,
pulito, abbagliante, refrigerante, con in fondo ogni sera lo
sguardo amico dei due fari di Livorno. Un gran giorno fu
quello in cui la figlia del prefetto di Massa lo fece salire
fino in casa, fino in salotto, per scegliersi due nastri e
sorridergli. Ma cosi non poteva durare. La stanchezza non
era soltanto fisica. Ghiglia mutava e mutava mestiere
sentiva ch'era vicino a schiantarsi, una sera o l'altra,
all'angolo d'una strada deserta. Una volta che tornò a
Livorno per rifornirsi di quei suoi scarti di magazzino,
giurò di non ripartirne più a nessun costo. Disegnava un
poco con le matite che vendeva. Conobbe due pittori giovani
come lui, Lloyd e Vinzio. Si dette a leggere Maupassant e
Zola. Riuscì a comprarsi dei colori. Riuscì a concentrare la
sua volontà in uno sforzo solo, verso uno scopo solo. E
vinse, prima di tutto, se stesso.
S'ammalò, si rimise su alla meglio e fu tolto dalla
fonderia. Un siciliano che commerciava in agrumi se lo portò
a Pistoia, sul mercato, tra le ceste d?aranci gialli e di
limoni verdi ; un grossista di Viterbo se lo portò a Viterbo
a vendere cioccolata, cotonate, colori. Nella mesticheria
del viterbese, Oscar Ghiglia ha primamente imparato i nomi e
le materie dei colori ; colori, s' intende, da imbianchino e
da verniciatore. Per allora non desiderava che maggior
liberta e perciò a diciassett'anni, quando i suoi bei
colleghi borghesi studiano calligrafia d'arte nelle
Accademie, si dette a fare il merciaio ambulante : tele,
nastri, stringhe, spille, bottoni e matite. Una cassetta
sulle spalle o un carrettuccio da spingere a braccia e via
sulle strade bianche di Lunigiana, a Serravezza, a Massa, a
Carrara, a Pietrasanta. Sole, polvere, fango e stanchezza ;
compagnie losche ; gergo di vagabondi ; lezzo d'osterie ; e
ad ogni svolta di strada il respiro del gran mare, libero,
pulito, abbagliante, refrigerante, con in fondo ogni sera lo
sguardo amico dei due fari di Livorno. Un gran giorno fu
quello in cui la figlia del prefetto di Massa lo fece salire
fino in casa, fino in salotto, per scegliersi due nastri e
sorridergli. Ma cosi non poteva durare. La stanchezza non
era soltanto fisica. Ghiglia mutava e mutava mestiere
sentiva ch'era vicino a schiantarsi, una sera o l'altra,
all'angolo d'una strada deserta. Una volta che tornò a
Livorno per rifornirsi di quei suoi scarti di magazzino,
giurò di non ripartirne più a nessun costo. Disegnava un
poco con le matite che vendeva. Conobbe due pittori giovani
come lui, Lloyd e Vinzio. Si dette a leggere Maupassant e
Zola. Riuscì a comprarsi dei colori. Riuscì a concentrare la
sua volontà in uno sforzo solo, verso uno scopo solo. E
vinse, prima di tutto, se stesso.
Nel 1900 come ho detto, potè venire a Firenze e parlare col
Fattori. Nel 1901, a venticinque anni già se ne stava, un
dipinto, in una Bella sala all'esposizione di Venezia,
seduto dentro una solida poltrona, guardando in faccia il
suo pubblico, reggendo nel pugno le definitive insegne del
suo potere, cioè del suo ingegno, tavolozza e pennelli. Non
c'era più da discutere e da dubitare almeno di fronte a se
stesso, al pubblico e ai colleghi. Ed ecco che subito,
appunto perchè aveva conquistate, egli detestò le
esposizioni. Gli apparvero quale appariva Roma a quell'altro
scontroso di Salvator Rosa.
Che di tre cose e l'abbondanza in Roma, Di
quadri, di speranze e baciamani.
Non tanto la sua fierezza e diffidenza erano offese da
quelle fiere quanto la stessa concezione dell'arte come
delicata confidenza e meditato abbandono. Ancora nel 1903
accettò di esporre a Venezia un ritratto : quello di sua
moglie, la quale ha davvero la metà di lui e della sua
energia. E' il più bello dei suoi ritratti, scultorio,
solido, pesante, in penombra, con gravi colori, turchini
notturni, bruni affocati, verdi d'alloro, in un'armonia
lenta e piena come d'organo. Ma gli altri ritratti di lui
non li amo. Egli non riesce a dominarvi il suo soggetto, ne
accetta di lasciarsene dominare e d'obbedirgli. Ne dipinse
fino al 1906. Poi nello stesso 1906 a Firenze e nel 1907 a
Faenza, nell'esposizione pel centenario del Torricelli,
apparvero di lui alcune piccole tele delle quali una m'è
rimasta indimenticabile, "Noia" : una modella ignuda
sopra un letto piatto, la faccia al muro, assopita, una
chitarra appoggiata al letto, una luce gialla uguale di
lampada. E quella di Faenza a stata l'ultima esposizione
alla quale egli ha partecipato.
|
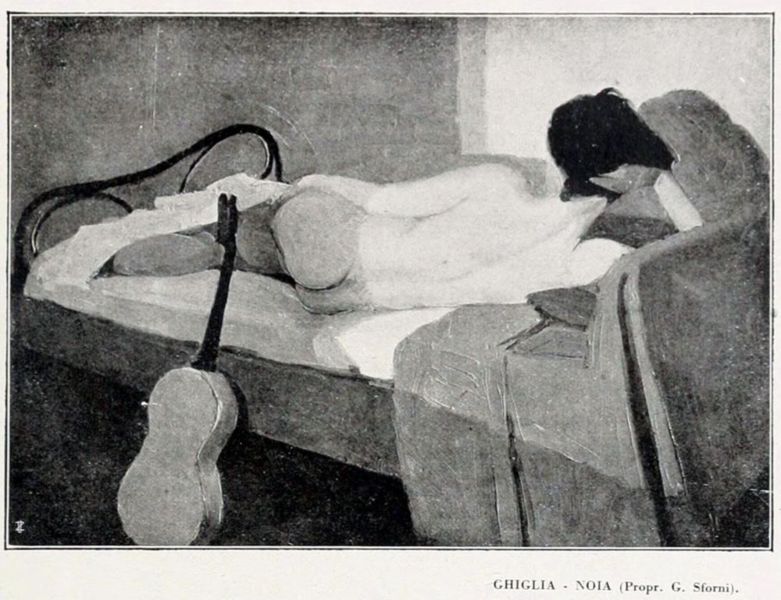 Cerca e cerca, egli aveva infatti trovato e toccato in
quelli anni il fondo semplice e sano dell'arte sua, e i suoi
limiti; e da allora ha stimato inutile o mortificante
confidarsi al pubblico. Chiuso in una casuccia di via
Boccaccio, una strada già campestre ai limiti di Firenze
verso San Domenico, infastidito dalla esterna fatica dei
ritratti d'ordinazione, egli aveva dunque cominciato a
dipingere, per suo sfogo e riposo, alcuni piccoli quadri di
commossa intimita familiare; a dipingerli con la sicura e
casta semplicità di colore e di taglio con cui gli
apparivano e lo commovevano. Quella malinconia di cui parlai
in principio, dopo tante iniquità e tradimenti della
fortuna, traboccò allora come mai nelle sue tele,
naturalmente e soavemente. Quel darsi senza abbandonarsi e
quel riprendersi senza abbandonare che è la propria natura
del poeta capace di trarre arte dai suoi affetti, ebbero in
quel chiuso il loro più libero gioco. Nella penombra intorno
a una cuna, nella luce quieta della cucinetta familiare,
nello splendore d'un fiore, d'un frutto, d'un gomitolo di
lana rossa dentro la pulita angustia della sua casa, quell'
intelligenza errabonda, sospettosa e orgogliosa, si acquietò
e si distese. Fu proprio da quell'osservazione placata e
amorosa dei fatti e oggetti più vicini e più umili, da quel
concentrare il suo fuoco in un sol tema dentro piccole tele,
badando a non disperderne una sola favilla, ch'egli è venuto
tardi a dipingere le sue cosi dette "nature Morte? con tanta
intensità di calore e di colore : sonetti in cui ha serrato
poemi, sonetti limati e battuti sillaba per sillaba, con
rime echi ed assonanze che si prolungano fuor della breve
realtà scritta o dipinta. Viveva allora tra gli scrittori
del Leonardo e poi della Voce : Papini, Prezzolini,
Vannicola, Amendola, gli erano amici quotidiani. Ma,
livornese sottile, non si lasciò sedurre dalle liriche
novità della letteratura e dell'arte, per poco,
d'avanguardia.
Cerca e cerca, egli aveva infatti trovato e toccato in
quelli anni il fondo semplice e sano dell'arte sua, e i suoi
limiti; e da allora ha stimato inutile o mortificante
confidarsi al pubblico. Chiuso in una casuccia di via
Boccaccio, una strada già campestre ai limiti di Firenze
verso San Domenico, infastidito dalla esterna fatica dei
ritratti d'ordinazione, egli aveva dunque cominciato a
dipingere, per suo sfogo e riposo, alcuni piccoli quadri di
commossa intimita familiare; a dipingerli con la sicura e
casta semplicità di colore e di taglio con cui gli
apparivano e lo commovevano. Quella malinconia di cui parlai
in principio, dopo tante iniquità e tradimenti della
fortuna, traboccò allora come mai nelle sue tele,
naturalmente e soavemente. Quel darsi senza abbandonarsi e
quel riprendersi senza abbandonare che è la propria natura
del poeta capace di trarre arte dai suoi affetti, ebbero in
quel chiuso il loro più libero gioco. Nella penombra intorno
a una cuna, nella luce quieta della cucinetta familiare,
nello splendore d'un fiore, d'un frutto, d'un gomitolo di
lana rossa dentro la pulita angustia della sua casa, quell'
intelligenza errabonda, sospettosa e orgogliosa, si acquietò
e si distese. Fu proprio da quell'osservazione placata e
amorosa dei fatti e oggetti più vicini e più umili, da quel
concentrare il suo fuoco in un sol tema dentro piccole tele,
badando a non disperderne una sola favilla, ch'egli è venuto
tardi a dipingere le sue cosi dette "nature Morte? con tanta
intensità di calore e di colore : sonetti in cui ha serrato
poemi, sonetti limati e battuti sillaba per sillaba, con
rime echi ed assonanze che si prolungano fuor della breve
realtà scritta o dipinta. Viveva allora tra gli scrittori
del Leonardo e poi della Voce : Papini, Prezzolini,
Vannicola, Amendola, gli erano amici quotidiani. Ma,
livornese sottile, non si lasciò sedurre dalle liriche
novità della letteratura e dell'arte, per poco,
d'avanguardia.
Quegli ingegni ansiosi, entusiasti e insofferenti, la loro
cultura varia e vasta in continuo divenire, le loro dispute
valorose che lanciavano gran reti di sofismi nel mar
dell'infinito per trarne almeno un pesciolino reale e
lucente da un marmo del tavolino al caffè in prova della
loro giovanile onnipotenza, se non convinsero sempre Oscar
Ghiglia, ne addestrarono però la curiosità e la dialettica
in difesa dell'arte che ormai era sua, delle certezze che
ormai lo confortavano. E adesso quelli amici, tornando "sui
quaranta, dalle loro esperienze e vagabondaggi, sono lieti
di ritrovarsi il loro Ghiglia fermo e sereno nel piccolo
mondo delle sue idee chiare e della sua soda pittura,
l'inesorabile Ghiglia che dieci anni fa, nel pieno del
tumulto tra postimpressionisti, cubisti e futuristi,
scriveva tranquillo questa paginetta, direi, morale:
"Dissipata quell'aureola di pittori rivoluzionari, per cui
anche i più mediocri fra gl'impressionisti furono notati e
commentati, chi rimase di costoro di cui l'opere dicano
qualcosa a noi che, avendo sorpassato la loro rivoluzione
che essi l'Accademia, non siamo soggetti a scambiare la
novità per genialità? Degas e Manet, la cui arte trascese i
preconcetti della scuola e gl?imperativi tecnici e si
affermò per ciò che aveva di personale da esprimerci.
Ma è sopratutto Cezanne (quel Cezanne che ormai i cubisti,
che sono nati dalle sue deficienze, vorrebbero superare,
ponendo l'arte alla pari di un qualunque processo di
fabbricazione di saponette, che si perfezionare aggiungendo
un pezzo alla macchina o un ingrediente all'impasto) e
soprattutto Cezanne che non volendo più saperne
d'impressionismo, di divisionismo, di complementarismo ,
ponendosi con occhi puri, mente sgombra, anima vergine in
cospetto alle cose, mirò non già a fare della "realtà"
il fine della pittura ma il tramite per cui la "sua anima
prodigava agli uomini quel sentimento sacro e profondo della
vita che sfugge loro nello sminuzzamento del vivere
quotidiano". Per cinque anni, dal 1915 al 1919, dopo una
lunga malattia, Oscar Ghiglia, lasciata Firenze, e andato a
vivere sul suo mare nativo, vicino a Livorno, a
Castiglioncello una spiaggia che, quando era quasi deserta,
fu cara a tutti i macchiaioli, al Fattori, al Lega, al
Signorini, per l'ospitalità di Diego Martelli. Ma ora a
Firenze è tornato, sulla collina d'Arcetri, tra querce ed
olivi. Ha quattro figliuoli. Due, Valente e Paolo, già
dipingono; e credo non passeranno molti anni che si dovrà
parlare anche di loro.
|
|
UGO OJETTI
|
|
(1) (1) L'opera di GIOVANNI FATTORI, 80 tay.
in fototipia,
Testo di OSCAR GHIGLIA (Firenze, Casa
editrice
Self, 1913).
|
|
|
|
|
|