| |
(Fonte : Emporium - n° 198 - Maggio 1911)
|
Pag. 1/2 |
|
Artisti contemporanei - Antonio Mancini
|
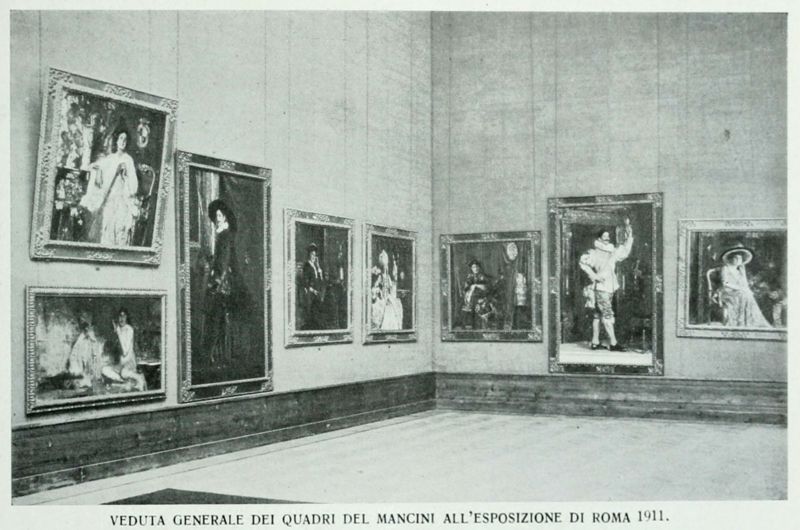 Un critico d'arte, che ne sapeva forse quanto i più moderni
letterati parigini che scrivono di pittura e di scultura
dando il tono ai colleghi europei, ossia il buon vecchio
Vasari, volendo lodare il ritratto della moglie di Francesco
Del Giocondo, quella sanissima Lisa, che oggi passa per una
sibillina figura di decadente, dice che in "quella testa,
chi voleva vedere quanto l'arte potesse imitare la natura,
agevolmente si poteva comprendere, perchè qui vi erano
contraffatte tutte le minuzie, che si possono con
sottigliezza dipingere".
Un critico d'arte, che ne sapeva forse quanto i più moderni
letterati parigini che scrivono di pittura e di scultura
dando il tono ai colleghi europei, ossia il buon vecchio
Vasari, volendo lodare il ritratto della moglie di Francesco
Del Giocondo, quella sanissima Lisa, che oggi passa per una
sibillina figura di decadente, dice che in "quella testa,
chi voleva vedere quanto l'arte potesse imitare la natura,
agevolmente si poteva comprendere, perchè qui vi erano
contraffatte tutte le minuzie, che si possono con
sottigliezza dipingere".
Decisamente a quei tempi contraffare la natura doveva essere
una faccenda molto più ardua che ai giorni nostri, perchè vi
si annetteva tanta importanza da costituire l'elogio supremo
d'un dipinto e d'un ritratto in ispecie. Oggi pare che ogni
lastra fotografica possa aspirare a questa gloria, giacche
molti pittori sdegnano di avere così modesto rivale e si
rifugiano nei campi ameni della decorazione, ossia della
semplificazione del vero, omettendo gran parte di quelle
minuzie inestricabili che si possono dipingere per
contraffare l'infinita complessità dei toni e dei piani che
avvolgono la superficie d'una forma fasciata per ogni parte
dalla luce.
|
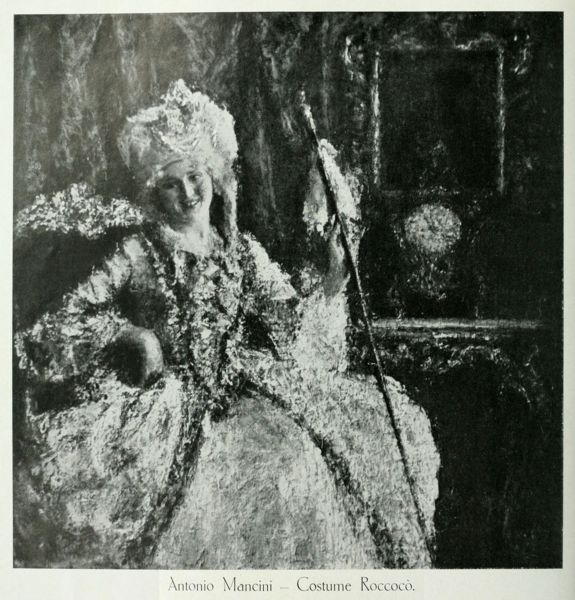 Per fortuna dell'arte, accanto a chi s'accontenta del
press'a poco, come un obbiettivo fotografico, c'è ancora
qualche pittore che ha fiducia nell'occhio umano, che lo
crede sempre capace di percepire l'individuo in tutta la
ricchezza della sua personalità fisica di forma e di colore
e in tutta la sua indeterminata complessità di carattere
psicologico. Uno di questi audaci ottimisti, anzi, il più
convinto di essi, è Antonio Mancini. Egli può ancora
dimostrare nelle sue tele, che a lottare davanti al vero con
la fotografia, la nostra retina è più intensa nella sintesi
e più penetrante nell'analisi.
Per fortuna dell'arte, accanto a chi s'accontenta del
press'a poco, come un obbiettivo fotografico, c'è ancora
qualche pittore che ha fiducia nell'occhio umano, che lo
crede sempre capace di percepire l'individuo in tutta la
ricchezza della sua personalità fisica di forma e di colore
e in tutta la sua indeterminata complessità di carattere
psicologico. Uno di questi audaci ottimisti, anzi, il più
convinto di essi, è Antonio Mancini. Egli può ancora
dimostrare nelle sue tele, che a lottare davanti al vero con
la fotografia, la nostra retina è più intensa nella sintesi
e più penetrante nell'analisi.
Il problema che si propone l'arte del Mancini è questo:
riprodurre la realtà secondo la visione che ne riceve il
nostro occhio quando si trova a tale distanza dalle forme da
poterle abbracciare nel loro insieme senza muoversi. Per
percepire una figura umana nel suo complesso, già Leonardo
insegnava che bisogna esserle distanti almeno tre volte la
sua altezza. Di lì il pittore antico faceva il disegno del
contorno; ma poi si avvicinava alla figura ogni volta che
doveva eseguire i particolari. L'arte moderna invece intende
contraffare la realtà così come appare nella sua sintesi di
forme e di tinte attraverso lo strato di atmosfera, che la
separa dall'occhio dell'artista, il quale perciò non può più
sopprimere quello strato con l'avvicinarsi per eseguire i
particolari.
|

 Ne segue che la visione moderna offre una illusione più
completa; poichè lo spettatore, arrivato allo stesso punto
di vista dell'artista, ha la percezione esatta d'una forma
avvolta dall'atmosfera, così come nel vero, ossia vista nel
suo ambiente, come si dice in gergo tecnico. il primo a
vedere e risolvere questo problema con piena coscienza è
stato Diego Velasquez sulla scorta di Tiziano e del
Tintoretto. Dopo di lui, per la legge stessa della pittura,
che tende al combaciamento perfetto della immagine finta
sulla tela e quella viva nella nostra retina, il problema
s'è imposto ogni volta che l'arte ha attraversato un periodo
o un cervello veristico.
Ne segue che la visione moderna offre una illusione più
completa; poichè lo spettatore, arrivato allo stesso punto
di vista dell'artista, ha la percezione esatta d'una forma
avvolta dall'atmosfera, così come nel vero, ossia vista nel
suo ambiente, come si dice in gergo tecnico. il primo a
vedere e risolvere questo problema con piena coscienza è
stato Diego Velasquez sulla scorta di Tiziano e del
Tintoretto. Dopo di lui, per la legge stessa della pittura,
che tende al combaciamento perfetto della immagine finta
sulla tela e quella viva nella nostra retina, il problema
s'è imposto ogni volta che l'arte ha attraversato un periodo
o un cervello veristico.
Il problema però è tanto facile ad essere formulato, quanto
ardua ne è la risoluzione; poichè a distanza le forme
perdono molto della chiarezza dei loro contorni e del loro
volume, per la corrosione, diciamo così, dell'atmosfera, che
fonde i margini e sopprime quelle sfumature, che
costituiscono proprio i fattoti del rilievo. Il verismo
della scuola impressionista risolveva molto semplicemente la
quistione, dando l'immagine confusa e piatta che appare
all'occhio al primo aspetto. Contro questa soluzione però
protesta sempre, inconsciamente, la persuasione del nostro
spirito, che sa dell'esistenza del volume delle forme per
scienza sua e per la tradizione della pittura analitica, che
eseguiva la figura pezzo per pezzo.
|

 Conciliare l'effetto di insieme con il rilievo delle parti è
dato solo alla potenza di poche retine privilegiate, che
riescono a percepire le più tenui sfumature dei particolari
e sanno valutarle nel giusto rapporto gerarchico con i toni
generali. E una sottile orchestrazione di infiniti valori di
tinte, che all'occhio comune non giunge nemmeno nella sua
quantità numerica di motivi e che ai grandi artisti riesce
così difficile da afferrare nell'esattezza precisa d'ogni
nota, che anche i più sicuri pittori d'ambiente sono quasi
sempre monocromi. Il Velasquez, Frans Hals e il Rembrandt,
in uno stesso quadro non si abbandonano a una tavolozza
molto abbondante, poichè se è difficile tener dietro alle
varietà d'una stessa tinta, la difficoltà si moltiplica
quando le tinte sono più d'una, e bisogna coordinarne
contemporaneamente le variazioni.
Conciliare l'effetto di insieme con il rilievo delle parti è
dato solo alla potenza di poche retine privilegiate, che
riescono a percepire le più tenui sfumature dei particolari
e sanno valutarle nel giusto rapporto gerarchico con i toni
generali. E una sottile orchestrazione di infiniti valori di
tinte, che all'occhio comune non giunge nemmeno nella sua
quantità numerica di motivi e che ai grandi artisti riesce
così difficile da afferrare nell'esattezza precisa d'ogni
nota, che anche i più sicuri pittori d'ambiente sono quasi
sempre monocromi. Il Velasquez, Frans Hals e il Rembrandt,
in uno stesso quadro non si abbandonano a una tavolozza
molto abbondante, poichè se è difficile tener dietro alle
varietà d'una stessa tinta, la difficoltà si moltiplica
quando le tinte sono più d'una, e bisogna coordinarne
contemporaneamente le variazioni.
Eppure il Mancini non cerca mai di evitare tale difficoltà;
anzi egli ama una colorazione ricca e varia quanto il vero,
senza predilezione alcuna di tonalità già da lui
conquistate. La novità però e la grandezza dell'arte sua non
consistono solo in questo; ma più specialmente
nell'intensità insuperata della sensazione luminosa della
sua policromia. Prima di lui solo Adolfo Monticelli, facendo
di tutte le tavolozze una profonda nutrizione,
riattaccandosi al Rembrandt, al Watteau e al Goya, riuscì a
fondere quella folle ridda di colorazioni violente, che dava
alle sue piccole fantasie il senso d'una intensità cromatica
non mai veduta fino allora.
|

 Il pittore marsigliese però, con tinte sincere,
spontaneamente avvicinate, s'accontentava di suscitare
nell'occhio dello spettatore l'immagine di forme intravviste
nel loro insieme, ma non chiaramente descritte e tanto meno
definite. La gloria di giungere a questa conquista, che pare
in assoluta antitesi con l'effetto sintetico a distanza, è
dovuta ad Antonio Mancini. Egli, per ottenere dalle tinte
opache dell'industria umana quella luminosità che è nelle
cose bagnate dai raggi solari, non usa valersi del reciproco
aiuto delle mezze tinte, che gerarchicamente collocate
riproducono la luce, in una scala però minore, più tenue,
più ammorzata, in penombra diciamo così: egli pretende dalla
luce l'effetto stesso ch'essa opera sulle superfici a
diversi piani, facendo lustrare e scintillare i più
rilevati. Perciò sulle paste a tutto corpo, che il nostro
pittore adopera anche per i fondi di tono più tenue,
sovrappone, conte rilievi cartografici di catene montuose,
quella quantità di colore che occorre per produrre riflessi
e penombre di piani rialzati.
Il pittore marsigliese però, con tinte sincere,
spontaneamente avvicinate, s'accontentava di suscitare
nell'occhio dello spettatore l'immagine di forme intravviste
nel loro insieme, ma non chiaramente descritte e tanto meno
definite. La gloria di giungere a questa conquista, che pare
in assoluta antitesi con l'effetto sintetico a distanza, è
dovuta ad Antonio Mancini. Egli, per ottenere dalle tinte
opache dell'industria umana quella luminosità che è nelle
cose bagnate dai raggi solari, non usa valersi del reciproco
aiuto delle mezze tinte, che gerarchicamente collocate
riproducono la luce, in una scala però minore, più tenue,
più ammorzata, in penombra diciamo così: egli pretende dalla
luce l'effetto stesso ch'essa opera sulle superfici a
diversi piani, facendo lustrare e scintillare i più
rilevati. Perciò sulle paste a tutto corpo, che il nostro
pittore adopera anche per i fondi di tono più tenue,
sovrappone, conte rilievi cartografici di catene montuose,
quella quantità di colore che occorre per produrre riflessi
e penombre di piani rialzati.
|
 La tecnica può parere paradossale, ed è certo pericolosa.
Infatti, siccome l'artista dipinge sempre con la luce di
fronte al quadro, se esso in una mostra viene collocato a
luce radente, non solo non si hanno più gli stessi riflessi,
ma la grossezza del colore produce delle ombre materiali,
che non erano nell'intenzione dell'artista. Così avviene che
le sue carni, potentemente vere, sotto certi effetti di
luce, sembrano opache. Di più, impostando, come fa il
Mancini, ogni tinta al massimo grado d'intensità, ossia al
grado di scintillio della tinta, quando si arriva ai colori
estremi, il bianco e il nero, non essendo essi capaci di
aumento, restano talvolta inferiori di voce al coro delle
colorazioni intermedie e riescono stonati. Ecco perchè il
pittore ama nei suoi quadri e sui bianchi lo sfolgorio
metallico di pietre preziose, di ori e di argenti, ed ecco
perchè egli è costretto a riprodurli non più con la pasta
colorante, ma con corpi, diciamo così, estranei, come pezzi
di vetro o di latta. Come si comprende, ciò non è un
capriccio di strano esteta, ma è il fatale prodotto logico
d'una intonazione già esasperata alle prime battute del
fondo.
La tecnica può parere paradossale, ed è certo pericolosa.
Infatti, siccome l'artista dipinge sempre con la luce di
fronte al quadro, se esso in una mostra viene collocato a
luce radente, non solo non si hanno più gli stessi riflessi,
ma la grossezza del colore produce delle ombre materiali,
che non erano nell'intenzione dell'artista. Così avviene che
le sue carni, potentemente vere, sotto certi effetti di
luce, sembrano opache. Di più, impostando, come fa il
Mancini, ogni tinta al massimo grado d'intensità, ossia al
grado di scintillio della tinta, quando si arriva ai colori
estremi, il bianco e il nero, non essendo essi capaci di
aumento, restano talvolta inferiori di voce al coro delle
colorazioni intermedie e riescono stonati. Ecco perchè il
pittore ama nei suoi quadri e sui bianchi lo sfolgorio
metallico di pietre preziose, di ori e di argenti, ed ecco
perchè egli è costretto a riprodurli non più con la pasta
colorante, ma con corpi, diciamo così, estranei, come pezzi
di vetro o di latta. Come si comprende, ciò non è un
capriccio di strano esteta, ma è il fatale prodotto logico
d'una intonazione già esasperata alle prime battute del
fondo.
|
|
Continua - Pagina 2/2
|
|
|
|
|
|
|
|