 Ma per fortuna il pittore, avvertito, già correva giù per la
collina al gran trotto del suo cavallo verso Francavilla. Da
quel che aveva veduto nella chiesa prima che San Pantaleone
uscisse al sole e soffrisse le indiscrezioni
dell'obbiettivo, egli aveva tratto il soggetto del quadro:
il busto del santo sopra un tappeto in terra tra sei
candelieri, i contadini la lingua per terra, striscianti e
sanguinanti dalla soglia della chiesa fino all'idolo che
abbracciavano singhiozzando e tremendo, il prete sereno e
sorridente sotto il gran piviale, inginocchiato lì presso
con l'aspersorio in mano, e dietro a lui la folla, uomini,
donne, vecchie, spose, infermi, bambini, tutti con un cero
in mano, l'anima negli occhi, estatici e dolenti.
Ma per fortuna il pittore, avvertito, già correva giù per la
collina al gran trotto del suo cavallo verso Francavilla. Da
quel che aveva veduto nella chiesa prima che San Pantaleone
uscisse al sole e soffrisse le indiscrezioni
dell'obbiettivo, egli aveva tratto il soggetto del quadro:
il busto del santo sopra un tappeto in terra tra sei
candelieri, i contadini la lingua per terra, striscianti e
sanguinanti dalla soglia della chiesa fino all'idolo che
abbracciavano singhiozzando e tremendo, il prete sereno e
sorridente sotto il gran piviale, inginocchiato lì presso
con l'aspersorio in mano, e dietro a lui la folla, uomini,
donne, vecchie, spose, infermi, bambini, tutti con un cero
in mano, l'anima negli occhi, estatici e dolenti.
Si badi. Una più tragica visione della vita paesana era
anche in Italia, nell'aria. Giovanni Verga aveva pubblicato
nell'80 la Vita dei Campi e nell'81 I Malavoglia
e si doveva parlar di verismo, nel senso francese e
pessimistico, anche al caffè di Pescara. In arte Millet,
morto nel 1875, cominciava ad essere conosciuto anche da noi
ed esaltato tanto che trovava degl'imitatori (a modo loro,
s'intende) perfino nella mite Toscana e che da qualcuno era
già proposto come il solo possibile contravveleno
all'ubbriacatura spagnola dei minuscoli epigoni fortuniani.
E d'Orsi aveva esposto a Torino, tre anni prima, il
Proximus tuus e due anni prima, a Milano, Patini, un
abruzzese, L'erede; e anche attorno ad essi,
imitazioni e plagi che non avevano avuto paura di ripetere
magari lo stesso titolo della statua o della pittura
imitata.
Si noti ancora. La trasformazione del Michetti è nel Voto
meno profonda di quel che si disse allora. Il soggetto
brutale è nuovo, ma la pittura resta la stessa: la stessa
luminosità dei singoli oggetti senza l'unità della luce
ambiente, lo stesso balzar in avanti di certe figure del
fondo, la stessa minuzia di certi particolari e lo stesso
sprezzo per certi altri, a capriccio, senza una logica
visibile, così che al quadro mancavano ancora il centro e
l'equilibrio, la stessa importanza data alla figura umana
fin nei suoi ornamenti e nei suoi fronzoli, la stessa
sommaria e fiacca pittura deí fondi, insomma la stessa
visibile ostentazione della propria maestria senza
un'austera ricerca di stile, che stile è rinuncia,
semplificazione, misura. Come nel Corpus Domini, come
nell'Ottava, come nei Morticini, anche nel
Voto, dopo la prima ammirazione, si poteva sentire che il pittore avrebbe
prodotto nello spettatore capace una più intensa emozione di
gioja, di pena, di ribrezzo, se si fosse meno disperso e
avesse voluto scegliere.
|
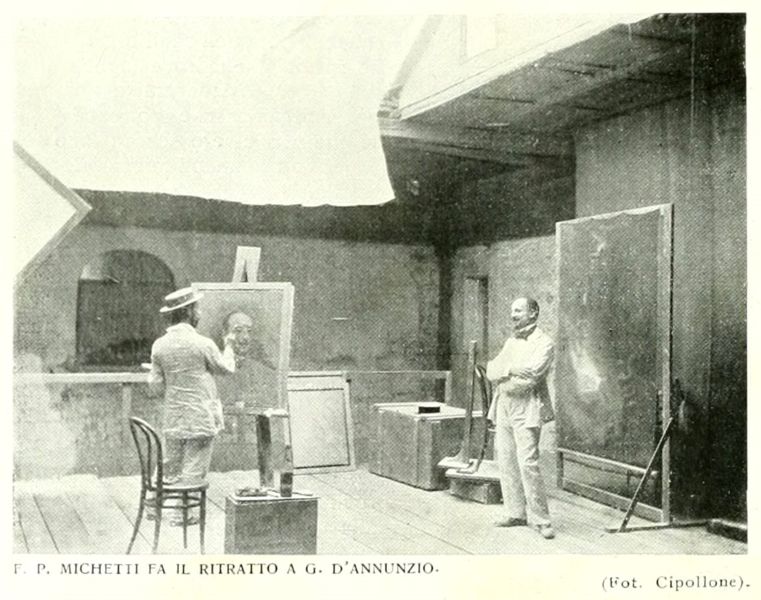 L'economia dell'attenzione è in pittura come in letteratura
una condizione per la intensità dell'emozione. E, da
Tintoretto a Millet, da Rembrandt a Boecklin, tutti i
pittori di sentimento e di passione hanno obbedito,
sapendolo o non sapendolo, a questa legge del minimo mezzo.
Michetti ancora non vi obbediva. Si poteva dire che egli
amava ancora sè stesso, la sua mano prodigiosa, la sua
acutezza d'osservazione più dell'arte, e preferiva ancora
far ammirare le proprie qualità di pittore più che il suo
quadro. Dal quale l'anima sua restava fuori. Nelle altre sue
opere, o la letizia primaverile o l'ebbrezza amorosa o la
tristezza autunnale o la nostalgia davanti a un tramonto sul
mare, eran visibili e comunicative anche se in quelle
maggiori e più affollate l'efficacia era stata, come ho
detto, diminuíta dalla dispesione delle parti. Ma qui,
creando il
Voto, che aveva egli sentito? Aveva forse, come più tardi nel Trionfo
della Morte Giorgio Aurispa davanti a uno spettacolo
simile, provato dentro quella chiesa "il disgusto per la
bestia immonda strisciante nella polvere consacrata"?
Esperimentando quella "aderenza materiale con lo strato
infimo della sua razza" aveva egli arretrato d'orrore o
aveva sorriso di scetticismo o aveva tremato per un
improvviso contagio di bestialità e di superstizione? Non si
capiva. Egli aveva dipinto quelle cinquanta figure del suo
quadro oggettivamente come si diceva in quelli anni in cui
si credeva nella favola d'un'arte oggettiva, cioè
macchinalmente (una macchina prodigiosa e perfetta,
s'intende) tanto che la pittura, ripeto, era stupefacente,
ma non il quadro.
L'economia dell'attenzione è in pittura come in letteratura
una condizione per la intensità dell'emozione. E, da
Tintoretto a Millet, da Rembrandt a Boecklin, tutti i
pittori di sentimento e di passione hanno obbedito,
sapendolo o non sapendolo, a questa legge del minimo mezzo.
Michetti ancora non vi obbediva. Si poteva dire che egli
amava ancora sè stesso, la sua mano prodigiosa, la sua
acutezza d'osservazione più dell'arte, e preferiva ancora
far ammirare le proprie qualità di pittore più che il suo
quadro. Dal quale l'anima sua restava fuori. Nelle altre sue
opere, o la letizia primaverile o l'ebbrezza amorosa o la
tristezza autunnale o la nostalgia davanti a un tramonto sul
mare, eran visibili e comunicative anche se in quelle
maggiori e più affollate l'efficacia era stata, come ho
detto, diminuíta dalla dispesione delle parti. Ma qui,
creando il
Voto, che aveva egli sentito? Aveva forse, come più tardi nel Trionfo
della Morte Giorgio Aurispa davanti a uno spettacolo
simile, provato dentro quella chiesa "il disgusto per la
bestia immonda strisciante nella polvere consacrata"?
Esperimentando quella "aderenza materiale con lo strato
infimo della sua razza" aveva egli arretrato d'orrore o
aveva sorriso di scetticismo o aveva tremato per un
improvviso contagio di bestialità e di superstizione? Non si
capiva. Egli aveva dipinto quelle cinquanta figure del suo
quadro oggettivamente come si diceva in quelli anni in cui
si credeva nella favola d'un'arte oggettiva, cioè
macchinalmente (una macchina prodigiosa e perfetta,
s'intende) tanto che la pittura, ripeto, era stupefacente,
ma non il quadro.
|
 Quella pittura, pezzo per pezzo, figura per figura, superava
per la varietà delle figure, la verità delle espressioni, il
vigore del disegno tutto quel che il "mago" aveva fatto fino
allora. E per questo gli studi che l'accompagnavano furono
tutti venduti in pochi giorni, a mille lire l'uno, e il
primo l'acquistò un pittore spagnolo, il Pradilla, e
ringraziò Michetti del regalo: lode pericolosa che voleva
inutilmente ricondurlo fra gli stanchi seguaci del Fortuny.
Alma Tadema scrisse allora a Domenico Morelli: "Michetti
est tout bonnement admirable: j'en suis fou". Ad inni
universali si opposero da un lato pochi "costaroli", o
discepoli di Nino Costa il quale in quelli anni si sforzava
di ricondurre l'arte italiana sugli ammaestramenti inglesi a
una semplicità e a un'ingenuità da primitivi e che appunto
l'anno dopo nella stessa Roma finiva a raccogliere il suo
gruppo nella società In arte libertas. L'articolo
romanescamente violento e inutilmente scortese che il Costa
scrisse contro il Voto partì da quel programma e fece
perciò un grande rumore. E il rumore crebbe quando la
commissione incaricata dal ministro delle compere ufficiali
(2) comprò tutto per quarantasettemila
lire — il Refugium peccatorum del Nono, il Bosco
di Castagni del Boggiani, il Mulino a Verona del
Bezzi, il Viaggio triste del Faccioli, un ritratto
del Tallone, ma non il Voto del Michetti. Poichè col
Michetti erano stati esclusi dalle compere anche il
Favretto, il Delleani, il Fattori, il Carcano, il Tito, il
Rossano, fu un urlo generale, da Torino a Napoli. I più
severi e meditati articoli in quella girandola di polemiche
furono scritti da Luigi Chirtani sul Corriere della Sera.
Quella pittura, pezzo per pezzo, figura per figura, superava
per la varietà delle figure, la verità delle espressioni, il
vigore del disegno tutto quel che il "mago" aveva fatto fino
allora. E per questo gli studi che l'accompagnavano furono
tutti venduti in pochi giorni, a mille lire l'uno, e il
primo l'acquistò un pittore spagnolo, il Pradilla, e
ringraziò Michetti del regalo: lode pericolosa che voleva
inutilmente ricondurlo fra gli stanchi seguaci del Fortuny.
Alma Tadema scrisse allora a Domenico Morelli: "Michetti
est tout bonnement admirable: j'en suis fou". Ad inni
universali si opposero da un lato pochi "costaroli", o
discepoli di Nino Costa il quale in quelli anni si sforzava
di ricondurre l'arte italiana sugli ammaestramenti inglesi a
una semplicità e a un'ingenuità da primitivi e che appunto
l'anno dopo nella stessa Roma finiva a raccogliere il suo
gruppo nella società In arte libertas. L'articolo
romanescamente violento e inutilmente scortese che il Costa
scrisse contro il Voto partì da quel programma e fece
perciò un grande rumore. E il rumore crebbe quando la
commissione incaricata dal ministro delle compere ufficiali
(2) comprò tutto per quarantasettemila
lire — il Refugium peccatorum del Nono, il Bosco
di Castagni del Boggiani, il Mulino a Verona del
Bezzi, il Viaggio triste del Faccioli, un ritratto
del Tallone, ma non il Voto del Michetti. Poichè col
Michetti erano stati esclusi dalle compere anche il
Favretto, il Delleani, il Fattori, il Carcano, il Tito, il
Rossano, fu un urlo generale, da Torino a Napoli. I più
severi e meditati articoli in quella girandola di polemiche
furono scritti da Luigi Chirtani sul Corriere della Sera.
Ettore Ferrari portò la questione alla Camera e Guido
Baccelli ministro dell'Istruzione nominò sei deputati -
Odescalchi pel Lazio, Martini per la Toscana, de Riseis per
le province dette napoletane, Crispi per la Sicilia, Perazzi
per tutta l'alta Italia, Salaris per la Sardegna — perchè
distribuissero (oh le idee artistiche del parlamento
italiano...) altre centocinquantamila lire in tre parti
uguali, una per l'Italia settentrionale, una per quella
centrale, una pel resto! E la commissione comprò finalmente
per quarantamila lire il Voto di Michetti. Lo sforzo
fu tanto che da allora, in ventisette anni, il governo non è
riuscito a comprare altro di lui che una Pastorella, una non
felice variante di quella della collezione Rotondo.
|
 Nino Costa in quel suo articolo fra molte iniquità aveva
scritto queste parole giuste: "Gran peccato che un uomo
tanto ben dotato dalla natura non sappia essere più
semplice, per la coscienza della propria forza". Non so se
il Michetti leggesse o, se lo lesse, meditasse questo
giudizio. Ho già indicato altre cause e altri esempi che
poterono subito dopo il Voto
spingerlo verso una semplificazione e verso una ricerca di
stile più vigile e più severa. Certo egli col Voto
aveva nella piena maturità del suo ingegno mostrato la
sincera volontà di rinnovarsi magari restando per qualche
anno in disparte. A Torino nel 1884 non espose che
acqueforti, scenette di campagna già da lui incise a Parigi
nella casa Cadart e pubblicate dal giornale L'Art chè
all'Istituto di Napoli egli aveva studiato anche incisione
con Aloisio Juvara: a Venezia nel 1887, fra alcuni dei
quadretti idillici che l'avevan condotto alla fama, non
mandò di nuovo che un ritratto — il ritratto della signora
Maria Bernadacki. Al ritratto si era dato in quelli anni con
passione e ne aveva fatti a olio del re, della regina, della
principessa Odescalchi (pel principe Baldassare Odescalchi
aveva dipinto anche un Innocenzo XI che fu donato al
Papa) e, a pastello, di sua moglie, di sua suocera, del
d'Annunzio. D'Annunzio nel 1893 scrisse che i ritratti del
re e della regina erano vere pagine storiche comparabili
certo nella bellezza al Francesco I di Tiziano, al
Giulio II di Rafaele, all'Almirante Pareja del Velasquez, al
William Waram di Hans Holbein. I paragoni erano un poco
contradditori e molto pericolosi: erano di maniera quanto
quel "Rafaele". E quelle due tele oggi nella galleria
veneziana d'arte moderna non sembrano più a nessuno degre ne
di Tiziano nè del miglior Michetti. Ma il poeta che per un
altro ritratto di Umberto aveva egli stesso indossato
l'uniforme reale e aveva posato davanti a Michetti per la
figura del re, vedeva giusto quando scorgeva in quei
ritratti e negli altri di quelli anni e nelle teste che poi
Michetti espose a Roma nel giugno del 1893, l'inizio per lui
di un periodo più tranquillo e più lucido, una maggior
purezza di pittura, uno sforzo costante a nascondere la
propria sapienza, a raggiungere una più schietta semplicità.
Nino Costa in quel suo articolo fra molte iniquità aveva
scritto queste parole giuste: "Gran peccato che un uomo
tanto ben dotato dalla natura non sappia essere più
semplice, per la coscienza della propria forza". Non so se
il Michetti leggesse o, se lo lesse, meditasse questo
giudizio. Ho già indicato altre cause e altri esempi che
poterono subito dopo il Voto
spingerlo verso una semplificazione e verso una ricerca di
stile più vigile e più severa. Certo egli col Voto
aveva nella piena maturità del suo ingegno mostrato la
sincera volontà di rinnovarsi magari restando per qualche
anno in disparte. A Torino nel 1884 non espose che
acqueforti, scenette di campagna già da lui incise a Parigi
nella casa Cadart e pubblicate dal giornale L'Art chè
all'Istituto di Napoli egli aveva studiato anche incisione
con Aloisio Juvara: a Venezia nel 1887, fra alcuni dei
quadretti idillici che l'avevan condotto alla fama, non
mandò di nuovo che un ritratto — il ritratto della signora
Maria Bernadacki. Al ritratto si era dato in quelli anni con
passione e ne aveva fatti a olio del re, della regina, della
principessa Odescalchi (pel principe Baldassare Odescalchi
aveva dipinto anche un Innocenzo XI che fu donato al
Papa) e, a pastello, di sua moglie, di sua suocera, del
d'Annunzio. D'Annunzio nel 1893 scrisse che i ritratti del
re e della regina erano vere pagine storiche comparabili
certo nella bellezza al Francesco I di Tiziano, al
Giulio II di Rafaele, all'Almirante Pareja del Velasquez, al
William Waram di Hans Holbein. I paragoni erano un poco
contradditori e molto pericolosi: erano di maniera quanto
quel "Rafaele". E quelle due tele oggi nella galleria
veneziana d'arte moderna non sembrano più a nessuno degre ne
di Tiziano nè del miglior Michetti. Ma il poeta che per un
altro ritratto di Umberto aveva egli stesso indossato
l'uniforme reale e aveva posato davanti a Michetti per la
figura del re, vedeva giusto quando scorgeva in quei
ritratti e negli altri di quelli anni e nelle teste che poi
Michetti espose a Roma nel giugno del 1893, l'inizio per lui
di un periodo più tranquillo e più lucido, una maggior
purezza di pittura, uno sforzo costante a nascondere la
propria sapienza, a raggiungere una più schietta semplicità.
L'effetto di questi propositi fu finalmente la grande
tempera della Figlia di Jorio che apparve alla prima
biennale di Venezia nel 1895 e che adesso è purtroppo nella
Galleria Nazionale di Berlino, col Ritorno e con
L'Ora triste
di Giovanni Segantini.
|
 Alle falde della Majella che biancheggia nel fondo, lungo un
ciglione, sul sentiero fangoso, passa la figlia di Jorio
(Jorio in abruzzese è Gregorio), la "cagna randagia", il
capo ammantato dal suo mantello rosso color di bucchero;
sull'orlo del ciglione sei uomini, giovani e vecchi, la
guardano cupidi e chi ride e chi ghigna e chi l'ammira
estatico; l'ultimo in piedi è decapitato dalla cornice
(3), un ramo nudo di mandorlo tende da
sinistra pochi fiori verso la bella desiderata, ma non si
vede l'albero che lo sostiene.
Alle falde della Majella che biancheggia nel fondo, lungo un
ciglione, sul sentiero fangoso, passa la figlia di Jorio
(Jorio in abruzzese è Gregorio), la "cagna randagia", il
capo ammantato dal suo mantello rosso color di bucchero;
sull'orlo del ciglione sei uomini, giovani e vecchi, la
guardano cupidi e chi ride e chi ghigna e chi l'ammira
estatico; l'ultimo in piedi è decapitato dalla cornice
(3), un ramo nudo di mandorlo tende da
sinistra pochi fiori verso la bella desiderata, ma non si
vede l'albero che lo sostiene.
Da venti anni Michetti pensava a quel tema che più tardi,
nel 1904, suggerì a Gabriele d'Annunzio la sua tragedia
pastorale. Prima ne aveva fatto un disegno ravvivato da due
o tre colori, intitolato La rejetta, e la donna vi
passava davanti a gruppi d'uomini e di donne che
confabulavano in aria dí mistero fuori d'un villaggio di cui
si intravvedevano tra gli alberi le prime case. In un altro
disegno sul quale era scritto Passione, scena umana,
una gran folla era fuori d'una chiesa e, proprio nel centro,
in un vuoto di ostilità, si vedeva passare una donna, curva
sotto uno sciale nero, con una mano sulla faccia, e il
tendone rialzato a metà sulla porta maggiore del tempio
recava — proprio così... — la parola
Caritas. Pian piano la scena si era semplificata, i costumi eran
diventati precisamente quelli di Orsogna, un caratteristico
paesotto in quel d'Ortona rinomato per una pittoresca
processione detta "dei Talami"; e non erano restati in
cospetto della Figlia di Jorio sopra una ripa verde
che cinque uomini: questa piccola tempera fu esposta a
Milano nel 1881. Ma in nessuno di questi e degli altri studi
e quadri preparatori, appariva ancora lo sfondo della
montagna azzurra e bianca, - alone niveo di purezza su quel
rosso peccato e quelle brame. E in nessuno — quel che più
importa — la pittura era squadrata con pochi piani e con
tanta fermezza e con tanta larghezza come nel quadro. La
donna e il giovane seduto nel mezzo del quadro e l'uomo
senza testa e un'altra mezza figura di donna che appare
ferma a destra, con una secchia sul capo, sembrarono
addirittura dipinte da un pittore a fresco che avesse
studiato Masaccio o Pier della Francesca e la loro pittura
statuaria. Niente fronzoli, niente particolari inutili: quel
che si doveva dire e niente altro. E l'uomo decapitato e la
donna tagliata a metà e il ramo di mandorlo senza tronco
pareva che fossero lì per dichiarare questa intenzione del
pittore di parlar breve e limpido, senza una sillaba di più
del necessario. Solo nel terreno schizzato con poca
consistenza era l'ultimo ricordo del Michetti beato di
mostrare la propria bravura.
|
 L'anno dopo egli vendeva — dicesi — per trecentomila lire al
signor Ernesto Seeger di Berlino quel quadro e tutto quello
che aveva nello studio — quadri ad olio e a tempera, e casse
e casse di pastelli e di guazzi, di appunti e di simili.
Quando nel 1889 partivo per Berlino per andare a vedere la
mostra di tutte quelle opere, egli mi disse: - Troverai là
tutto il mio lavoro di venti anni. Le pareti, le casse, le
tavole del mio studio sono vuote. Ricomincio da capo, — e
sorrideva agile e sano, soddisfatto di quella seconda
giovinezza, felice di ritrovarsi davanti alla vita con occhi
nuovi e con un bel sole di gloria sull'aperto orizzonte.
L'anno dopo egli vendeva — dicesi — per trecentomila lire al
signor Ernesto Seeger di Berlino quel quadro e tutto quello
che aveva nello studio — quadri ad olio e a tempera, e casse
e casse di pastelli e di guazzi, di appunti e di simili.
Quando nel 1889 partivo per Berlino per andare a vedere la
mostra di tutte quelle opere, egli mi disse: - Troverai là
tutto il mio lavoro di venti anni. Le pareti, le casse, le
tavole del mio studio sono vuote. Ricomincio da capo, — e
sorrideva agile e sano, soddisfatto di quella seconda
giovinezza, felice di ritrovarsi davanti alla vita con occhi
nuovi e con un bel sole di gloria sull'aperto orizzonte.
A Berlino la Figlia di Jrio del 1895 era esposta di
contro al Corpus Domini del 1877. Tra quei due poli
era chiusa tutta la nobilissima vita di questo solitario che
aveva lavorato per venti anni a domare la facilità e
l'irruenza del suo genio e a trovargli uno stile: una vita e
un esempio.
Perchè da allora Michetti non ha più esposto un dipinto che
continuasse la matura e virile bellezza di quella sua
tempera? Il quadro l'Offerta che fu donato dalle dame
e dai gentiluomini di Corte alla nuova regina d'Italia per
le sue nozze, i disegni per la Bibbia d'Amsterdam esposti a
Roma nel 1902, d'una forza tragica contenuta con tanta
fermezza nella osservazione del vero che parvero, meno il
Saul, troppo realistici in un momento in cui la pittura
religiosa già tornava mistica e fantastica, sono sembrati
passatempi per chi a quarantaquattro anni aveva costruito
quel monumento. D'altra parte le due grandi tempere esposte
a Parigi nel 1900, I Serpenti e Gli Storpii,
parvero un ritorno alle intemperanze dei primi anni.
Raffigurava la prima una processione attraverso un prato
verdissimo, sullo sfondo d'una chiesa dal portico alto e
affrescato, con confraternite di uomini e gruppi di donne e
di bimbi in vesti violentemente policrome, tutti cinti di
serpi verdastri e sul collo, sulle braccia, sulle croci, sui
ceri; e la seconda, alcuni selvaggi episodi del
pellegrinaggio di Casalbordino già descritto dal d'Annunzio
nel Trionfo della Morte, cioè sotto un ripone giallo
e riarso cinque o sei gruppi di storpii mostruosi e
d'infermi protesi verso la croce che passa, spasimanti a
implorare il miracolo. V'erano i soliti suoi pezzi
d'incomparabile bravura, ma v'era anche quella sua antica
ostentata noncuranza per la prospettiva lineare, per l'unità
della luce, per la composizione o almeno per
quell'equilibrio dei colori e delle masse che forma il
quadro e toglie allo spettatore il fastidio di sentirsi
davanti a un frammento, a un'opera inorganica che potrebbe
continuare ancora per metri o essere senza danno
dell'effetto tagliata ancora in frammenti minori. E, del
resto, da allora, silenzio.
|
La psicologia degli artisti vivi è difficile a definirsi.
Quella degli antichi è più facile non solo perchè tutte le
opere vi stan davanti alla mente e tutte le ipotesi sono
lecite e anzi le più ardite e scortesi hanno il miglior
successo, ma anche perchè gli artisti sulle cui vicende lo
psicologo o lo storico o il critico s'affaccendano, son
dalla morte costretti a tacere. Invece sull'apparente
inerzia di Francesco Paolo Michetti non è chi non dica la
sua. E v'è chi ne dà la colpa alla sua clausura in
provincia, anzi in campagna, lontano dalle lotte e dalla
concitazione e dall'emulazione delle città. E v'è chi la
attribuisce a una specie di disgusto per l'arte venutogli
dalla stessa facilità con cui ormai egli lavorava, perchè il
piacere di creare vien solo dal dolore della gestazione. E
v'è chi trae da qualche frase pessimistica del Michetti la
conclusione che dopo il 1896, dopo Adua, e dopo la
rassegnazione con cui gli italiani sembrano aver accolto la
sconfitta, egli ormai disperi dell'avvenire della patria, e
il lavoro gli sembri faticoso davanti a un pubblico sempre
più meschino e sempre più egoista. E v'è anche fra gli
artisti più giovani chi dice che il Michetti, tenutosi
lontano a parole e a fatti da tutti i più recenti dibattiti
sulla tecnica e sugli ideali della pittura — dibattiti che,
del resto, sono un plagio tardivo di quelli di venti e
trent'anni fa in Francia - , non abbia più voglia di esporre
quadri per sentirsi, nel pieno vigor dell'ingegno,
proclamare un superstite.... Tutte ipotesi e probabilmente
tutte ciancie.
Michetti, certo, non se ne cura e forse nemmeno le sa. Su
lui come sul suo d'Annunzio, chi li conosce da vicino, sa
che è da savio non fare profezie perchè oggi essi sono, come
venti anni fa, capaci di far ammutolire critici e profeti
con una opera sola, inattesa, e oggi, conte vent'anni fa,
una cosa sola sembra impossibile a guardarli e a udirli: che
invecchino. Intanto Michetti continua a vivere, a studiare,
a cercare, a meditare in un'attivissima pace nella sua
Francavilla tra la collina e il mare presso la sua donna
Annunziata, moglie e madre esemplare, presso la sua bella e
dolce figliola Aurelia dai capelli neri, presso il suo
Sandro che si è impiantato lassù tutt'un laboratorio di
chimica e di meccanica. E nella cella del Convento di Santa
Maria Maggiore dove Gabriele d'Annunzio tant'anni fa ha
scritto il Piacere e ha sognato la sua Elena Muti
sotto la coperta di seta fina "d'un colore azzurro disfatto"
ricamata niente meno che coi dodici segni dello Zodiaco e
proveniente niente meno che dal corredo di Bianca Maria
Sforza, le buone e sane donne di casa Michetti hanno posto
una macchina da cucire e cuciono i loro semplici lini
profumati di spigo.....
|
Ugo Ojetti
|
|
Pagina
1 |
2 |
3 |
4
|
|
|
|